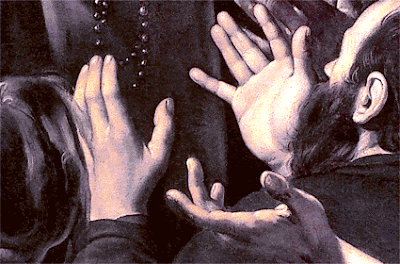L'Occidente, figlio della cultura greca, si caratterizza per il primato della vista, rispetto ad altri sensi. Se da Gerusalemme e dalla radice ebraica viene il richiamo all'ascolto, e quindi all'udito come organo della conoscenza, da Atene deriva l'importanza del vedere, come attesta tutta la produzione - ricchissima - dell'arte occidentale, interpretata quale via di accesso alla verità, via semplice e aperta a tutti.
 |
| L'Occidente e il primato della vista... |
Lo sguardo interiore.
Lo sguardo segna in modo irripetibile il nostro stare
al mondo e i significati di fondo con cui, consapevoli o passivi, lo
abitiamo: è segno conoscitivo centrale per eccellenza. Ma non guardiamo solo
fuori di noi: volenti o nolenti, per prima cosa vediamo noi stessi,
prima di tutto c’è il nostro sguardo interiore (intus-legere),
“il conosci te stesso”, l’apertura
a noi stessi, consapevole od inconscia, immediata o riflessa,
sicuramente distorta se non diviene movimento che
caratterizza l’interiorità della persona, un ri-prendersi e
ri-possedersi, condizione – se ne è parlato in un precedente post –
dell’abitare il mondo e di socializzare senza
infingimenti.
 |
| ... guardare dentro ... |
Lo sguardo sul mondo.
Allora lo sguardo si fa propriamente apertura
alla realtà esterna: è il primato della vista che si identifica da sempre con il conoscere,
come attesta il lessico greco del vedere.
Per Platone è
«filosofo» chi ama «lo spettacolo della verità», chi esercita la visione
del bene culmine della conoscenza, liberandosi dalla zavorra delle opinioni
inautentiche. Per Aristotele il desiderio di sapere nasce dalla meraviglia di
ciò che si vede.
 |
| ... guardare fuori: la meraviglia della realtà ... |
Lo sguardo sedotto.
Ma lo sguardo può essere offuscato dall’abbagliamento
della seduzione: come nel racconto di Medusa, figura bellissima quanto
perversa, che riesce ad affascinare quegli uomini che si voltano a guardarla,
trasformandoli in pietra o come nel mito di Narciso che si lascia sedurre
dal proprio riflesso nell'acqua rivelando tragicamente il cortocircuito
dell'ego.
 |
| Medusa - la realtà tentacolare - che seduce e spaventa... |
 |
| Narciso: la malattia dell'ego ... |
Lo sguardo che non vede.
Già Pascal affermava: "troppa luce
abbaglia", ad indicare la debolezza dello sguardo umano, impossibilitato a
vedere fino in fondo. E che dire del mito platonico della caverna - metafora
della condizione umana -, in cui il prigioniero crede di vedere la
realtà, mentre intravvede solo ombre? O della cecità tragica di Edipo, o
di Tiresia che proprio perché cieco ha preveggenza aperta al
futuro, mentre gli è negata la percezione del presente?
 |
| ... troppa luce abbaglia ... |
I miti rivelano, nella declinazione dello
sguardo-conoscenza, la natura originaria di uno sguardo che non può essere mai
esaustivo, che è sempre parziale, che può però sempre indicare nuovi
indizi di avvicinamento alla realtà esterna, in una reversibilità degli sguardi
tra l’uomo e il mondo che rende possibile l’esistenza
del visibile e dell’invisibile: anche in mezzo al deserto ci sentiamo
guardati, anche nella solitudine più assoluta possiamo sentire la compagnia di
uno sguardo.
 |
| ... l'invisibile (in questo quadro il fascio di luce che non proviene dalla finestra) è condizione del visibile (in questo quadro la scena). |
Lo sguardo oggi.
Oggi viviamo in un contesto
sociale e culturale dedito alla fobia dello sguardo, alla miopia:
vediamo solo quello quello che vogliamo
vedere - non vidi ergo non est… - oppure ci fanno vedere solo
quello che vogliono e c’ è chi si industria a non farci vedere, a
distrarci, a velare lo sguardo, ad impedirci ogni stupore e meraviglia
che muove ed incita lo sguardo. Mai chiudere gli occhi di fronte alla
realtà al mondo. Mai essere ciechi per non vedere volutamente: poiché chiudere
un occhio è permissivismo, chiudere entrambi gli occhi è complicità viltà
servilismo.
 |
| ... chiudere gli occhi è complicità ... |
Ritrovare uno sguardo
lucido.
Solo in un caso, ci suggerisce
Derrida, vale la pena chiudere gli occhi: quando non è un assentarsi dal
mondo ma vederlo meglio per meglio viverlo ed abitarlo,
perché – aggiunge - non bisogna semplicemente vedere con gli occhi,
occorre anche pensare con gli occhi a costo di doverli chiudere per ritrovare
anzitutto se stessi. Destino della finitudine umana tra presenza ed assenza.
 |
| ... prendere distanza, per vedere meglio ... |
|
|
|
Tutte le immagini riproducono opere di Michelangelo Merisi da Caravaggio.
Chi
desidera intervenire può consultare il post del 22/10/13 oppure
semplicemente andare qui sotto su "commenta come", nel menù a tendina
selezionare "nome/URL", inserire solo nome e cognome e cliccare su
continua. Quindi può scrivere il proprio contributo sul quale rimarrà il
suo nome ed eventualmente, se lo ritiene opportuno, può lasciare la sua
mail.