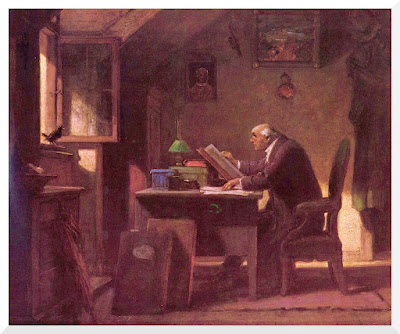Post di Rosario Grillo
 |
Gabriel Pacheco
|
“ Desiderio! La tua intensità mi trafiggeil petto.
Tu rendi possibile l’impossibile
partecipi della natura dei sogni - come può essere?
Sei complice dell’irreale
e ti accompagni al nulla”
(W. Shakespeare, il racconto d’inverno).
In una breve storiella Kafka descrive il filosofo nella figura dell’appassionato al gioco della trottola.
Più da vicino: è, costui, inesorabilmente attratto dal gioco infantile della trottola quando interrompe i bambini, per il gusto “frenetico” di girare, lui, la trottola. Ma, altrettanto “bruscamente”, getta poi via, indispettito, la trottola.
Il gioco e l’attrazione, con il goffo finale, si ripeterà giorno dopo giorno.
È il ritratto della follia.
💥 Fermiamoci un attimo. La follia: non nel segno dell’irrazionale, dell’opposto alla ragione; ma nel segno del “di più” della ragione e/o del diverso da essa. (1)
Furono i greci, a cominciare dai poeti, a scoprire tale virtù, rappresentandola nei versi riferiti ad Eros. (2)
Da Saffo ad Archiloco, nel magma delle vicende amorose,è descritta un’azione di Eros, che, al culmine, viene riassunta e spiegata dai dialoghi di Platone (in specie nel Convivio e nel Fedro).